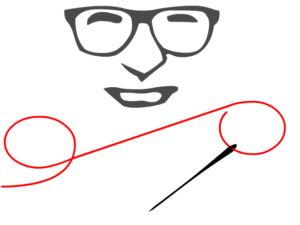
Riflessioni ad alta voce
L’impegnativa eredità di Papa Francesco, sperando che non si disperda
Alessandro Lauro*
La scomparsa di Papa Francesco e la fine del suo pontificato segnano un passaggio storico che sarà di assoluta rilevanza per la Chiesa cattolica, l’Italia e non solo.
Si sono sommati e si sommeranno ancora molteplici ricordi, fiumi di inchiostro scorreranno per ricordare, celebrare il pontificato, in alcuni casi forse anche per lamentarne le carenze. Si tratteranno tanti aspetti di questi dodici anni e forse alcuni di questi intercettano gli interessi e le sensibilità di chi partecipa all’Associazione dedicata a Valerio Onida, sia dal punto di vista culturale del cattolicesimo democratico, sia sotto l’aspetto dell’approccio costituzionalistico ad un’analisi delle vicende storiche nel loro farsi. Questo breve commento abbraccia proprio questa prospettiva, se vogliamo storico-politica, separata da disquisizioni ed analisi teologiche.
L’ascesa di Francesco al soglio pontificio ha sparigliato le carte: il collegio cardinalizio del 2013, un collegio in parte corrispondente a quello che elesse Benedetto XVI, ed in parte composto da prelati da questi nominati, elesse vescovo di Roma un personaggio che non poteva essere più diverso da Ratzinger. Non solo nei modi e nell’aspetto pubblico, ma anche nelle tematiche scelte, nell’approccio ai problemi e alle sfide contemporanee della Chiesa.
La prima rivoluzione di Papa Francesco è stata quella di scompaginare gli asseti ideologici di “destra” e “sinistra”, soprattutto in Italia, ma forse in Europa: politici che concionavano alle folle brandendo rosari, invocando i valori tradizionali, “non negoziabili”, superiori ecc… si sono trovati all’improvviso privati di una loro legittimità ideologica, di fronte ad un magistero che, spogliandosi di una certa retorica magniloquente, ha evangelicamente rimesso al centro gli ultimi, gli emarginati e, forse, anche i “peccatori”. Chi predicava i porti chiusi, rivendicando le radici cristiane dell’Europa, si è trovato un Vicario di Cristo che bollava come falsi cristiani coloro che lasciavano morire in mare i migranti.
Le parole papali sono risuonate sempre più nette contro una visione dell’economia capitalista spinta, priva di remore morali, che mette il profitto al di sopra della dignità umana. Gli insegnamenti del papa hanno ricominciato con forza a guardare ai bisogni contemporanei (come la difesa dell’ambiente) come una questione di giustizia anzitutto umana, cioè come fenomeni che colpiscono e danneggiano anzitutto i più fragili della Terra e di cui occorre farsi carico.
Ed in questo Francesco ha disarmato pure la sinistra politica, ormai sempre più china alle idee liberali e liberistiche, che all’improvviso ha sentito risuonare nei Palazzi Apostolici una voce in grado di proferire parole sempre meno frequenti nella sfera pubblica e sempre più difficili da pronunciare, anche a sinistra.
In un mondo in cui proliferano le guerre, e l’Occidente le sostiene con argomenti più o meno nobili, Papa Francesco ha sempre denunciato l’ipocrisia della produzione e del commercio di armi, che all’Occidente sempre conviene e spesso è dimenticata anche nelle “parole di pace” delle istituzioni politiche.
Un punto essenziale dell’eredità culturale di Francesco, che probabilmente trascende i recinti della Santa Romana Chiesa, è quello di aver abbandonato l’eterno desiderio clericale di distinguere perennemente fra i “giusti” e gli “ingiusti”, i “probi” ed i “peccatori”, per rifocalizzare le energie ecclesiastiche sulla lotta alle diseguaglianze ed alle ingiustizie.
L’azione di Bergoglio, tanto progressista per alcuni, è stata invece criticata da molti altri, perché troppo debole nei suoi risvolti concreti. Spesso, non è stato soddisfatto quel desiderio “normativistico” di cambiare le regole, i canoni, la dottrina. Ma chi è abituato ad osservare le evoluzioni istituzionali con una prospettiva di medio o lungo periodo non può non riconoscere che Papa Francesco forse non è stato un riformatore in sé, ma è stato il promotore di processi di riforma, probabilmente irreversibili. Ha inclinato dei piani, che sembravano immobili, con la consapevolezza che non si può innovare una cultura bimillenaria dall’oggi al domani.
Tutto può sembrare insoddisfacente: ma sentire dal Papa che chi ama persone dello stesso sesso è figlio di Dio quanto gli altri, che chi non è “in regola” con le prescrizioni (umane) non è invero lontano dall’Amore divino (i risposati e tanti altri), ha in sé qualcosa di estremamente più rivoluzionario della riscrittura di un canone o di un capitolo del Catechismo. Durante il Giubileo della misericordia del 2015 venne addirittura riconosciuta l’indulgenza, per la prima volta nella storia, a chi avesse abortito o procurato aborti. Basti pensare a quanto tutto ciò fosse impensabile sotto i pontificati di Wojtyla o di Ratzinger.
Papa Francesco ha aperto più dibattiti di quanti ne abbia chiusi o ne abbia potuti chiudere, senza ammantarsi dell’infallibilità: il diaconato femminile (con una prospettiva di lungo periodo al sacerdozio), il celibato del clero, la benedizione delle unioni omosessuali ecc.
E sono passati solo dodici anni, un nonnulla nello scorrere della storia.
In questi dodici anni, la Chiesa è tornata ad avere una sua autorità morale riconosciuta e riconoscibile nel mondo, anche dai non cattolici. Ciò ha innescato anche alcuni cambiamenti nella percezione dei rapporti fra la sfera civile e la sfera religiosa. Magari è troppo – e troppo poco argomentato – sostenere che Francesco ha cambiato l’idea di laicità, ma forse non è azzardato sottolineare come il magistero di Papa Francesco abbia all’improvviso fatto sembrare “meno inutile” la dimensione religiosa ed ecclesiastica, soprattutto in Paesi che la guardano, ormai da decenni, se non secoli, con sospetto. Il caso più significativo è quello della Francia, dove anche i media di certo non filo-cattolici (un esempio per tutti: il quotidiano Le Monde) hanno tributato una copertura del tutto rilevante alle parole del Papa ed alle sue azioni, durante tutto il pontificato. Come a dire: “ecco perché ancora esiste”.
E nei Paesi dove, non solo la cultura cattolica, ma anche il potere ecclesiastico è molto radicato, le cose sono percettibilmente cambiate. L’Italia è l’esempio migliore: quanto tempo sembra passato da quando il cardinale Ruini conduceva campagne elettorali per i referendum del 2005 sulla legge 40, senza mai astenersi dal dare consigli di voto in tutte le altre tornate elettorali (ovviamente per un determinato schieramento). Oggi, quando parlano i prelati della CEI (pensiamo al cardinale Zuppi) ci sono valori da promuovere, non contrassegni elettorali da sponsorizzare.
Insomma, l’eredità di Papa Francesco, forse non sufficientemente “normativa” per alcuni, è in realtà l’innesto di principi che troveranno nella storia il modo di svilupparsi, di approfondirsi e forse di resistere a venti che oggi sembrano violentemente spirare in altre direzioni rispetto a quelle che indicava il Papa.
Forse, c’è da auspicare che la saggezza dei cardinali elettori sappia cogliere questi principi e trovare il magistero adatto a custodirli e ad implementarli, senza paura di “spiacere” ai grandi della Terra.
* Università Ca’ Foscari di Venezia – Université Paris Panthéon Assas
